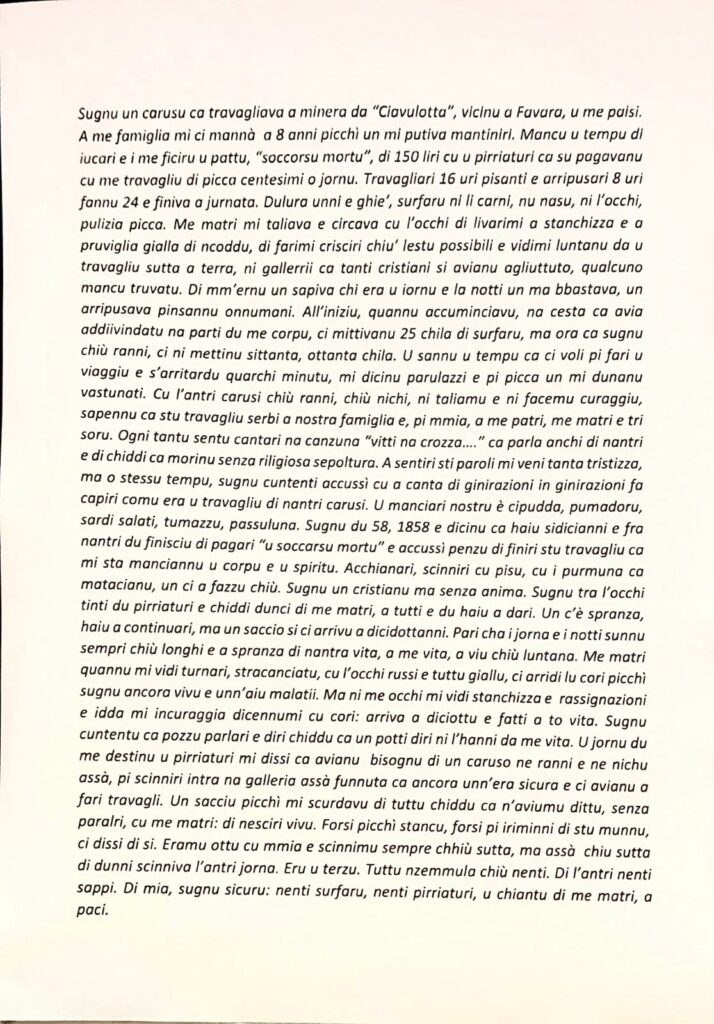Antonio Magro dà voce a uno dei carusi morto assieme ad altri otto zolfatai nella tragedia del 1874 in una galleria della Ciavolotta. Un mondo crudele vissuto dai ragazzini schiavi del sottosuolo

I carusi delle zolfare, gli schiavi-bambini siciliani del XIX-XX secolo. Il lavoro era durissimo, molto pericoloso, usando semplicemente pale, picconi, ceste per il trasporto dello zolfo. La figura chiave nel sistema estrattivo era il picconiere (pirriaturi) che staccava il materiale dalle gallerie. In un sistema feudale, arcaico, in cui il padrone chiedeva la gabella (il 40-50% del materiale estratto) al capo picconiere, si sviluppò una forma di sfruttamento della manodopera non troppo lontana dallo schiavismo, soprattutto per l’impiego del carusi, ragazzi tra i sette e i sedici anni di età, consegnati dalle famiglie contadine povere per procurarsi una fonte di guadagno dai loro bambini.
Lavoravano dalle 10 alle 16 ore, trasportando tra gli stretti passaggi delle miniere carichi di 20-25 kg per i bambini più piccoli e fino a 70-80 chili per ragazzi di 16-18 anni. Questa manodopera veniva pagata direttamente dal picconiere, con una formula chiamata “soccorso morto”: ai genitori veniva data in anticipo una somma di 100/150 lire, che andava riscattata con il lavoro del figlio. I pochi centesimi giornalieri rendevano praticamente impossibile l’estinzione del debito, mentre il lavoro faticoso cui erano sottoposti li faceva crescere spesso storpi o rachitici. Lo scrittore afroamericano Booker T. Washington, un ex schiavo, nel 1912 scrisse a proposito dei carusi: nessuna crudeltà simile è mai stata segnalata nella schiavitù dei negri; quando i pestaggi non erano sufficienti, venivano loro bruciati i polpacci con le lanterne per rimetterli di nuovo in piedi. Innumerevoli furono gli incidenti mortali nelle solfare.
 Chi scrive, nel racconto dialettale che seguirà, dando voce a “carusu” del 1858, data di nascita di suo Nonno paterno anche lui zolfataio e probabile carusu testimone dell’evento, si rifà a un fatto realmente accaduto nel 1874 nella miniera Ciavolotta di Favara, dove, in seguito ad uno smottamento di una parete di una galleria, persero la vita otto persone tra minatori e carusi, alla poesia di Ignazio Buttitta “a li Matri di Carusi” e alla novella “Rosso malpelo” di Verga. Far parlare direttamente “u carusu” ha suscitato grande emozione allo scrivente, quasi a risuscitarlo e permettere di esprimere non solo il suo dramma, ma anche il suo senso della famiglia per l’impegno preso con il picconatore, l’amore indissolubile per la mamma e la grande voglia di vivere al di fuori dell’inferno della miniera, una volta riscattato il debito.
Chi scrive, nel racconto dialettale che seguirà, dando voce a “carusu” del 1858, data di nascita di suo Nonno paterno anche lui zolfataio e probabile carusu testimone dell’evento, si rifà a un fatto realmente accaduto nel 1874 nella miniera Ciavolotta di Favara, dove, in seguito ad uno smottamento di una parete di una galleria, persero la vita otto persone tra minatori e carusi, alla poesia di Ignazio Buttitta “a li Matri di Carusi” e alla novella “Rosso malpelo” di Verga. Far parlare direttamente “u carusu” ha suscitato grande emozione allo scrivente, quasi a risuscitarlo e permettere di esprimere non solo il suo dramma, ma anche il suo senso della famiglia per l’impegno preso con il picconatore, l’amore indissolubile per la mamma e la grande voglia di vivere al di fuori dell’inferno della miniera, una volta riscattato il debito.
La sua fanciullezza, dagli otto ai sedici anni, è svanita facendo posto alla maturità per l’impegno, soverchiante la sua età, che aveva preso. Le parole di “Vitti na crozza…” venivano canticchiate e tramandate oralmente dai minatori di detta miniera e l’arrangiamento musicale è stato composto dal musicista empedoclino Franco Li Causi nel 1950 in occasione del film “Il cammino della speranza” di Pietro Germi, le cui prime scene sono state riprese a Favara.
ECCO IL RACCONTO DIALETTALE